 L’aikidò 合気道 (scritto in kanji) o anche 合氣道 (usando un kanji più antico) è una disciplina psicofisica giapponese praticata sia a mani nude sia con le armi bianche tradizionali del Budo giapponese, di cui principalmente: “ken” (spada), “jo” (bastone) e “tanto” (il pugnale).
L’aikidò 合気道 (scritto in kanji) o anche 合氣道 (usando un kanji più antico) è una disciplina psicofisica giapponese praticata sia a mani nude sia con le armi bianche tradizionali del Budo giapponese, di cui principalmente: “ken” (spada), “jo” (bastone) e “tanto” (il pugnale).
I praticanti sono chiamati aikidoka.
La disciplina dell’aikido fu sviluppata da Morihei Ueshiba, anche chiamato dagli aikidòka òsensei (“Grande maestro”), a cominciare dagli anni trenta del ‘900.
L’Aikido deriva principalmente dall’arte marziale del Daitò-Ryù Aikijùjutsu, dalla quale però iniziò a prendere le distanze, sviluppandosi come disciplina autonoma, a cominciare dalla fine degli anni Venti.
La finalità dell’aikido non è rivolta al combattimento né alla difesa personale, pur utilizzando per la sua pratica una tecnica che deriva dal Budo, l’arte militare dei samurai giapponesi. L’aikido mira infatti alla “corretta vittoria” che consiste nella conquista della “padronanza di se stessi”, resa possibile soltanto da una profonda conoscenza della propria natura interiore. Con questo, il fondatore dell’aikido voleva affermare che per cambiare il mondo occorre prima cambiare se stessi e ciò significa che se si vuole veramente acquisire quella capacità di padroneggiare l’attacco proveniente da un potenziale avversario esattamente nell’istante e nella circostanza della sua insorgenza, occorre aver prima acquisito la capacità di padroneggiare se stessi.
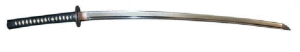
L’aikido, pur discendendo quindi direttamente dal Budo giapponese e pur conservando e utilizzando nella sua pratica tutto il bagaglio tecnico di un’arte marziale, non è tuttavia finalizzato al combattimento e quindi a un risultato di tipo militare o di difesa personale, come potrebbe apparentemente sembrare osservando la sua pratica dall’esterno, ma è finalizzato al risultato della scoperta e dello studio delle leggi di natura che regolano le dinamiche e le relazioni che entrano in gioco nel rapporto fra gli individui, nell’occasione dell’instaurarsi di un conflitto e/o un combattimento fra di loro. L’aikido non condivide la finalità dell’uccisione dell’avversario e neppure dell’offesa dell’avversario allo scopo di realizzare una difesa personale. L’aspetto dell’arte marziale e/o della difesa personale si riconducono all’aikido solamente in modo indiretto, quale elemento secondario della pratica.
Benefici fisici
È ormai un dato di fatto, acquisito e riconosciuto scientificamente che l’esercizio fisico è molto importante per il mantenimento di una buona salute. D’altra parte il corpo umano, “progettato” per cacciare, coltivare, spostarsi a piedi su lunghe distanze, produrre manufatti, manifesta il suo disagio nella sedentarietà della vita odierna, inquinata e stressante, soccombendo a malattie che, paradossalmente, sono definite “del benessere”. Ecco allora spiegata la sempre più diffusa richiesta di praticare attività fisiche che aiutino l’uomo a salvaguardare la propria salute e che possano far fronte alla perdita di necessità ataviche, sacrificate alla “civiltà”.
In questo campo l’Aikido può senza dubbio distinguersi per efficacia e completezza, agendo in modo benefico sia sul corpo che sulla psiche di chi vi si dedica. Poiché l’Aikido è movimento, infatti, offrirà tutti i vantaggi che il movimento dà al nostro organismo, ben studiati e documentati dalla Medicina Ufficiale. Avremo vantaggi per l’apparato locomotore, con il mantenimento della calcificazione ossea, della tonicità muscolare e dell’elasticità delle articolazioni. Per l’apparato respiratorio, con un aumento della propria capacità funzionale. Per l’apparato cardiocircolatorio, con un miglioramento della sua resistenza allo sforzo e della sua possibilità di perfusione sanguigna di tutto l’organismo. Per il metabolismo, con un aumentato consumo di glucosio, colesterolo, trigliceridi, sostanze dannose all’organismo quando vi si trovino in eccesso, o favorendo la produzione di colesterolo Hdl, ottimo per mantenere le arterie “pulite”. Per il sistema immunitario, stimolato ad una maggiore attività nei suoi compiti di difesa dall’esercizio fisico. Per il sistema nervoso e la psiche, con il mantenimento di riflessi rapidi, capacità di osservazione, disciplina dell’ aggressività. Senza dimenticare, infine, che l’Aikido, nell’esecuzione delle sue tecniche, è scarsamente traumatico e fa muovere ogni segmento del corpo in modo pari, sia a destra che a sinistra, con la caratteristica delle attività fisiche globali e complete. L’Aikido inoltre è strettamente correlato alla Medicina Tradizionale Orientale, secondo le cui conoscenze il benessere psicofisico dell’uomo dipende dall’equilibrio tra l’energia vitale che permea ogni individuo e l’energia cosmica che lo circonda. L’Aikido va alla ricerca proprio di questo. I suoi movimenti, le sue tecniche, le prese, le cadute, non sono altro che massaggi e stimolazioni su punti di comando dei canali di scorrimento dell’energia che gli agopuntori cinesi da secoli hanno codificato e descritto sul nostro corpo come “meridiani energetici”. Ne consegue che ogni organo, ogni viscere, ogni apparato collegato a questi meridiani riceve una sollecitazione salutare durante la pratica, un arricchimento energetico con riflessi positivi anche sull’equilibrio psichico.
La terapia del dolore
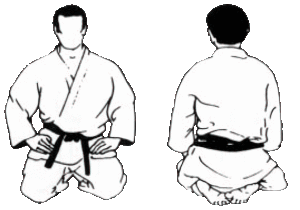 Noi associamo spesso al dolore qualcosa di negativo o di sbagliato nell’ Aikido invece il dolore è parte integrante dell’ arte marziale. Il dolore diventa “benefico” perché permette uno scioglimento delle articolazioni e dei muscoli unendo così il potenziamento con l’allungamento. La posizione del seizà, in ginocchio, usata molto spesso per il “saluto” o per l’inizio delle “tecniche”, è dolorosa e scomoda, ma permette di stare con la schiena dritta e di avere dei benefici anche con il passare degli anni.
Noi associamo spesso al dolore qualcosa di negativo o di sbagliato nell’ Aikido invece il dolore è parte integrante dell’ arte marziale. Il dolore diventa “benefico” perché permette uno scioglimento delle articolazioni e dei muscoli unendo così il potenziamento con l’allungamento. La posizione del seizà, in ginocchio, usata molto spesso per il “saluto” o per l’inizio delle “tecniche”, è dolorosa e scomoda, ma permette di stare con la schiena dritta e di avere dei benefici anche con il passare degli anni.
Come dice sempre il mio maestro:
La disciplina
L’aikido richiede prima di tutto rispetto e disciplina. La divisa è costituita: da un kimono d’aikido fatto di cotone spesso, dalla cintura del colore del grado acquisito e dalle ciabatte di bambù. La lezione ha una forte base ritualistica e quindi esistono dei canoni da eseguire:
Preparazione del tatami: una volta per turno una persona si deve occupare di allestire il tatami. Prima di tutto si dovrà togliere le ciabatte, che dovrà poi indossare nuovamente ogni volta che uscirà da questo spazio. Controllato lo stato del tatami, l’allievo dovrà uscire e prendere la rastrelliera delle armi del maestro e il quadro del fondatore della scuola. Quando poi avrà portato la rastrelliera all’interno del tatami e l’avrà sistemata in una posizione predefinita (varia di dojo in dojo) eseguirà un seizà di fronte a essa. A quel punto l’allievo appenderà il quadro del fondatore, sopra ad essa, ed eseguirà anche di fronte a lui il saluto. Successivamente il praticante che si è occupato della preparazione dovrà richiedere le armi al maestro. Ottenuto il consenso le prenderà dalla sacca. Da quel momento le armi saranno sotto la sua responsabilità. Portate dentro le armi eseguirà un’altra volta il seizà.
Ingresso: quando si entra nel tatami bisogna fare il saluto a tutti, quindi appena entrarti ci si inginocchia e si fa il seizà. A quel punto si inizia a fare un po’ di straching e qualche caduta. Quando entra il maestro tutti si devono interrompere e girarsi verso il punto dove si trova il maestro ed eseguire lo seizà. Successivamente si eseguirà il saluto comune che ha delle forme precise. Gli allievi si devono mettere in ordine per cintura e per età (dal più anziano al più giovane) e per sesso (prima gli uomini).
Le tecniche: dopo che il maestro ha spiegato la tecnica da eseguire si cerca un compagno, o in alcuni casi si fa gruppo unico, e gli si fa il saluto a quel punto si può iniziare a fare la tecnica. Il maestro intanto gira per il tatami e da spiegazioni a quelli che hanno dubbi o non stanno eseguendo correttamente la tecnica. Gli allievi a cui viene fatta la spiegazione devono ringraziarlo facendo lo seizà.
Conclusione della lezione: la lezione si conclude rifacendo il saluto fatto all’ inizio. Dopo fatto il saluto un allievo va dal maestro e gli chiede il permesso di piegare la sua hakama, la gonna-pantalone, anche questo va fatto secondo uno specifico rituale. Intanto gli altri possono uscire ad eccezione del allievo che piega la gonna e dell’ altro allievo, che inizialmente aveva montato la rastrelliera, che dovrà smontare il porta armi, riportare fuori le armi e riconsegnarle al maestro.